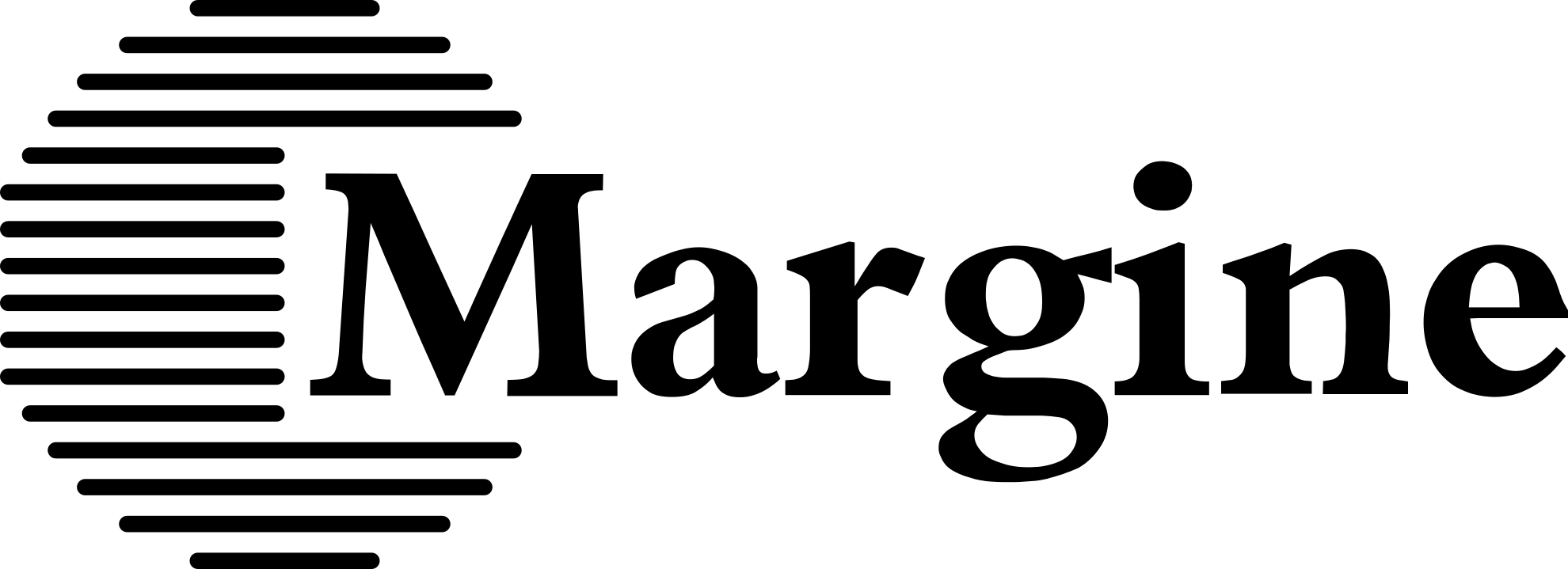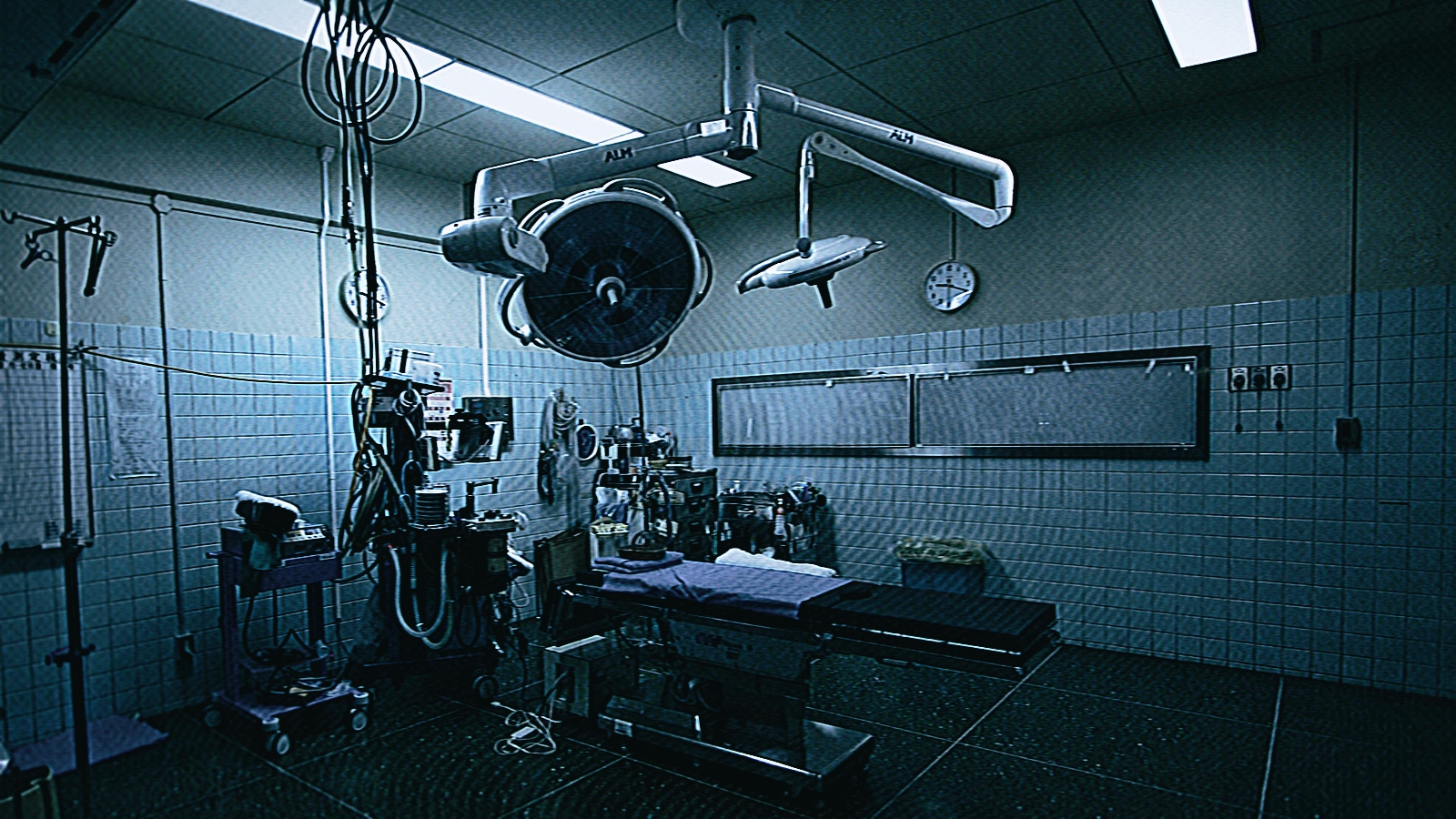Destino e memoria

Destino e memoria
La mano che tendevo agli sconosciuti forzando un sorriso di circostanza è stata tradita infinite volte. Piacere, dicevano tutti prima di ricordare il proprio nome, e qualcuno dovrebbe spiegarmi se ci sia davvero qualcosa di piacevole nell’ingannare sé stessi impegnandosi a stabilire un nuovo legame. Gli occhi incuriositi di ogni interlocutore in cui mi imbatto emanano sempre un’aria di fragilità, e io non vi leggo altro che la solita profezia: condivideremo momenti, spazi ed emozioni finché qualcosa non ci priverà all’improvviso di questa possibilità. Allora, forse a nostra insaputa, ci staremo scambiando uno sguardo per l’ultima volta. Continuo a vedere questa spada che pende sul capo di ogni Damocle che incontro. Marta mi ha detto che ha un nome preciso: “abbandono”.
Non si è mai davvero pronti ad affrontare un abbandono. Mi è capitato di parlare con un amico. «Ho deciso di lasciare mia moglie», diceva, e lo guardavo domandandomi se si rendesse conto del fatto che decidere di abbandonare la propria moglie non sia, in fin dei conti, affatto diverso dall’essere abbandonato. Questa falsa convinzione nasce da ragazzi, quando l’esistenza inizia a rivelare la caducità dei rapporti, che vengono svuotati della possibilità di essere vissuti ulteriormente quasi senza nessun comprensibile preavviso. Allora pensavo che l’angoscia nascesse dalle circostanze fortuite che mi impedivano di mantenere un legame stabile con chi mi stava attorno. Proprio perché improvvise, tali circostanze dovevano essere involontarie. Se invece avessi avuto il potere di scegliere da me quando e come compiere un abbandono, avrei dovuto sopportare il solo rimorso di avere causato una qualche sofferenza.
«Non sei tu a causare la sofferenza.» diceva Marta porgendomi una sigaretta. «La sofferenza è propria di ogni abbandono. Sia che si scelga di abbandonare, sia che non si scelga di essere abbandonati, si prova lo stesso senso di smarrimento.»
«Allora, quando non vorrai più offrirmi le tue sigarette e farmi questi discorsi, soffrirai come me?» le chiesi.
Rispose qualcosa sussurrando.
Poche cose posso dire con certezza di Marta. Quando l’ho incontrata l’ultima volta, aveva scolpite sotto gli occhi socchiusi due rughe già adulte, la sua pelle si era fatta più dura, le dita si erano ingiallite attorno alle unghie pigramente smaltate. Non somigliava alla ragazza che si riparava dalla pioggia di settembre con una giacca azzurrina e mi correva davanti. La sua voce era cambiata con gli anni, insieme a tutto il resto. Restava solo il suo fascino ingenuo. “Tu” scrissi di lei quando riempivo le mie giornate di illusioni puerili, “non sai quanto mi è chiaro il tuo sorriso. Perché tu sei tu, e questo non ti sembrerà granché guardandoti riflessa in uno specchio. Se solo una volta potessi essere l’altro, se solo una volta potessi incontrare te stessa fuori di te, forse allora conosceresti la tua eccezionalità.”. Non ho mai lasciato che leggesse queste parole. Innanzitutto, non le avrebbe trovate granché interessanti. In secondo luogo, non volevo correre il rischio che le fraintendesse dando loro un significato frivolo. Infine, mi piace immaginarla ancora e sempre inconsapevole, smarrita in un dedalo interiore che non le permette di capire quanto sia spontaneo il suo sguardo.
Non sapevo che non l’avrei più rivista. Il bus correva per le strade gelide di un inverno qualsiasi e le gocce di pioggia scivolavano sul vetro disegnando nuovi contorni alle case del centro storico. Lei mi stringeva le mani e guardava fuori dal finestrino. La sua testa riposava sulla mia spalla. Ricordai le parole di Marta:
«Sorridi. È forse l’unica maniera che abbiamo per mostrarci grati di per questi momenti e averne un buon ricordo, nonostante tutto.»
Quando Marta era lontana, e ancor più quando mi era vicina, la vita mi sembrava una trama complessa di abbandoni. Era stata lei a farmi pensare, in un primo momento, che esistesse un modo per affrontarli, ma anche questa era un’illusione. D’altronde, non esiste una via d’uscita al vuoto. E l’abbandono è proprio questo: una sensazione di vuoto, una destituzione della propria volontà, sia che lo si compia, sia che lo si subisca, ammesso che cambi davvero qualcosa. Destino, per me, significava dare un senso a quegli abbandoni. Trovare una giustificazione che li spiegasse, una logica dietro le scelte che portavano a spezzare anche il legame più stabile. Soltanto comprendendo questo avrei potuto vincere la sofferenza: ancora alimentavo l’anima di propositi impossibili.
Una volta credevo che il destino parlasse del futuro. Lo immaginavo come un percorso del quale non si possono comprendere le direzioni, forse solo intuirle. Niente di più sbagliato. Non esiste un destino senza una memoria che suggerisca una direzione necessaria a quel sentiero. Il destino, a me, iniziava a parlare del passato. Quando Marta una volta era andata via, non sapevo se l’avrei incontrata di nuovo, ma potevo già dire, in un certo senso, che il nostro destino restava l’abbandono. E non lo dicevo sulla base delle circostanze future a me ignote, ma delle certezze che il passato aveva dato a entrambi.
Anni dopo, fui io a decidere – e volevo farlo davvero – di abbandonarla, e mi sforzai scioccamente di cercare il suo consenso a quella che da parte sua era vista come una vera e propria violenza ingiustificata. Insomma, dimenticavo che nessuna parola sarebbe stata in grado di calmare il suo pianto. Sprecavo invano il mio fiato a farle sembrare ragionevole quello che non avrebbe mai potuto trovare accettabile, e avrei tanto voluto dirle: «lo sapevi! sin dal primo momento, sapevi che ci saremmo perduti!». Non lo sapeva, non poteva vederlo con la mia stessa chiarezza. Perché lei era lei, e non si era mai vista da fuori, non si era mai considerata effimera come i petali di un fiore di pesco.
Qualcuno ancora vede al destino come il sentiero che va in avanti e si perde nel misterioso orizzonte, col sospetto che conduca davvero da qualche parte prestabilita. Ma la destinazione è sempre frutto di una memoria: solo i ricordi possono dare uno scopo o un senso al cammino. Ci si strugge, si arde di passione come candele senza saperne il motivo, e quando ci si spegne infine si dice: “illuminavano la notte”.
Quando le dissi di come avevo vissuto l’abbandono, sfogliava un libro con fare distratto. Era nuda nella stanza in penombra. Le pareva tutto già chiaro e non mi ascoltava più. Mi chiese:
«Questa paura ti ostacola?»
«Paura?»
«La consapevolezza della fine dei rapporti.»
«Se ne avessi paura, farei di tutto per evitarla. Invece te ne parlo, perché voglio che tu sappia questo, che anche se un legame è putrefatto ancor prima di nascere, lo vorrò ugualmente stringere con tutte le mie forze. Nonostante il dolore, nonostante la sofferenza. Se d’altronde si vive per morire, si nasce già un po’ morti; e se ci si conosce per abbandonarsi infine, ci si vede già un po’ abbandonati.»
A me piaceva guardarla negli occhi, quegli occhi piccoli e giudici che si aspettavano un passo falso di lì a breve, mentre tacevamo, e lei poggiava una mano sulla guancia come chi aspetta un treno in ritardo. E d’altra parte il mio enigma consisteva proprio in questo: nel ritardare il più possibile il momento in cui avremmo fatto i conti col motivo reale per il quale ci incontravamo a casa sua, mi offriva un goccio di liquore amaro e mi parlava di sé. L’abbandono arrivò lento, atroce, portando con sé innumerevoli rimpianti.
«Hai paura.» disse Marta quella notte. «Hai paura che ti abbandoni.»
Lo avevamo già fatto entrambi e lei non lo sapeva, anima inquieta che sospira nel buio.
L’unica amarezza che porta un’assenza improvvisa è quella di non essere in grado, in un primo momento, di ripensare a sé stessi fuori dal legame concluso. Ci si vede ancora un poco immersi in una storia già finita con la speranza vana di poterla cambiare. Eppure, mi accorsi di non inseguire Marta, di non cedere a promesse disattese ancor prima di essere fatte, mi parve piuttosto che fosse lei a farmi visita ogni tanto, per pormi ancora le stesse domande e avere in risposta parole che il tempo aveva solo in parte cambiato.
Qualche tempo dopo proiettavo sullo specchio un’aria stanca. Non ero più abituato all’idea che il primo volto a dover vedere ogni mattina fosse il mio. E guardando le lenzuola ripiegate su sé stesse in un groviglio che non volevo disfare, pensavo di opporre al destino dell’abbandono la forza di un eterno ricordo. Credevo di giacere da solo su quel letto: un’ombra, eppure, vi riposa ancora insieme a me ogni notte.
Proprio perché non posso dimenticarla penserò al suo abbandono come si pensa a qualcosa di necessario, di inevitabile. Perché si possa parlare di destino è necessario avere memoria. E avrò memoria di lei per sempre, anche se mi piacerebbe dimenticarla, per convincermi del fatto che non è vero che la vita è fatta di soli abbandoni, ma anche di ritrovamenti.
Infine, ci salutammo come se avessimo trascorso una giornata qualunque. Non sapevamo che non ci saremmo visti un’altra volta, anche se le avevo sussurrato “addio” dopo un bacio veloce sulla guancia e lei non si era più voltata a vedermi andare via. Non l’avrei davvero più rivista. L’avrei forse ritrovata nello sguardo di un’altra, nei modi di fare di una nuova sconosciuta, nella dolce tristezza di un volto ignoto ancora. E avrei continuato a dare a tutto ciò il nome dello stesso ricordo, dello stesso tormento, dello stesso destino: Marta, voce di incanto e nostalgia.