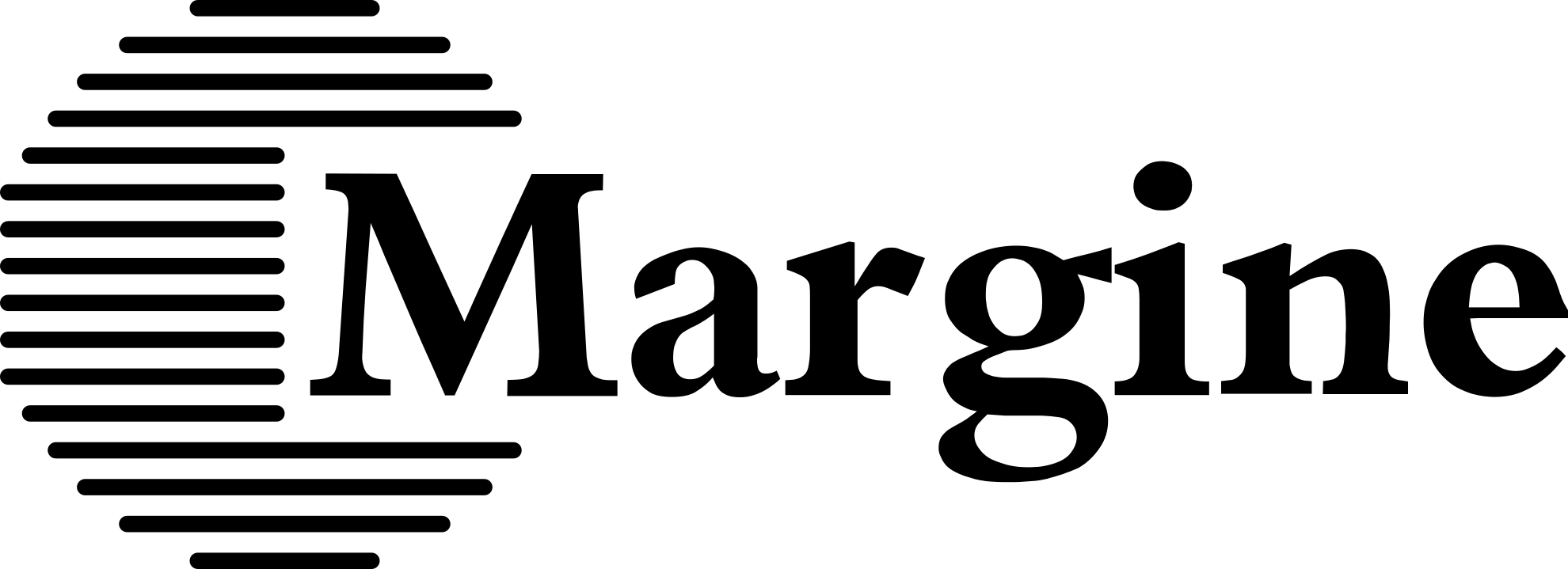La balconata

La balconata
Quei giorni sono una serie di istantanee inzuppate in una noia molle. Per rivedere le immagini impresse devo strizzare via i richiami della famiglia, le loro costrizioni, i piatti di plastica, i pranzi al sacco e l’angoscia grigia di quella libertà sorvegliata da bambini che sembra fin troppo quella dei cortili delle carceri. Allora scorgo un cielo che non sembra quello di oggi (eravamo troppo piccoli per vederlo allo stesso modo), le dune e il velo della sabbia sotto ai piedi, il sale del mare, la coperta muschiosa di un monte a picco sull’acqua. E un passaggio tra i rovi, appena fuori dalla spiaggia. Ma andiamo con ordine. Era la solita villeggiatura di agosto: come sempre la meta era cambiata rispetto all’anno precedente, per dar sollievo alla mania di novità di mia madre. Come sempre, scorgevo l’occhio vigile di mio padre dietro i lettini, dietro gli angoli dei camper, persino dietro le onde mentre facevo il bagno. Ormai ero abbastanza grande da averci fatto l’abitudine; non abbastanza da guardarmi le gambine dove spuntavano i primi peli, quelle che martoriavo sugli scogli e sfregavo sulla sabbia, e immaginare che un giorno sarebbero state diverse.
Saremmo rimasti lì per un mese. Veterano com’ero, mi ero già circondato di un gruppetto di amicizie di convenienza: altri come me, sperduti o sotto la stretta sorveglianza dei genitori, accomunati da quella stessa noia molle di cui vi parlavo. I volti e i nomi di questi bambini sono sovrapposti a quelli delle villeggiature precedenti (non di quelle successive, perché non ce ne sono state) e a quelli dei miei amici di una vita, che mi aspettavano nelle piazze squallide e liquefatte della mia città natale. Questi legami da villeggiatura erano sempre di una forza inaspettata. Ogni nuova amicizia era la continuazione dell’amicizia di un’estate precedente, incarnata in un nuovo bambino di passaggio, che condivideva qualche tratto caratteriale con quello vecchio e finiva inevitabilmente per ricoprire lo stesso ruolo nel gruppetto. C’era quello più affine, con cui sembrava di essere amici da sempre; quello scemo, a cui si voleva bene e che era utile come bersaglio delle nostre prese in giro (per sviluppare un certo cameratismo con gli altri, oltre che un comune senso dell’ironia); la ragazzina, che veniva contesa tra almeno due degli altri (io di solito guardavo); l’amica della ragazzina, che solitamente era un po’ meno aggraziata, ma era un’ottima consigliera; lo spericolato, che di tanto in tanto si rompeva una gamba e finiva per ritirarsi prematuramente dalla villeggiatura; il finto maturo, che rubava le sigarette al padre e si faceva comprare la birra da un amico più grande; poi lo spontaneo e il credente, il cicciotto e l’atletico, il fuori luogo e il popolare…
Vivevamo sospesi tra la plastica rovente dei tavolini degli stabilimenti, i crepuscoli e i tornei a palla in acqua (succedeva che il tonto schiacciasse sul maturo e tutti lo portavamo in trionfo; o che l’atletico abbattesse tutti gli altri per farsi notare dalla ragazzina). La sabbia si ficcava fin dentro le custodie sventrate delle carte da gioco. Era un tempo eterno e finito. Alla seconda settimana sembrava di stare lì da sempre e che si sarebbe rimasti lì per sempre. Poi, verso la fine della terza, i ragazzini cominciavano a svanire, il gruppetto a sbiadire e decimarsi, e si capiva che la piccola eternità volgeva al termine. Sognavamo tutti casa sin dal primo giorno. Ma sulle ultime battute della vacanza casa era diventata la spiaggia e la separazione sembrava una condanna fatale. Allora la solita noia molle fremeva di un male incurabile, come se improvvisamente avesse deciso di voler essere sopraffatta da qualcosa di grande, di vivo. La storia che vi voglio raccontare è ambientata all’inizio della quarta settimana, in questi giorni da moribondi.
La sorveglianza di mio padre si era leggermente allentata. Sentivo che mi erano state finalmente date in mano le chiavi del mondo. Ormai, però, eravamo in pochi: ricordo altre tre, forse quattro figure senza forma, coi capelli mori e biondi, i denti dritti e l’apparecchio, le braccia lunghe e una statura minuta. La ragazzina, di cui solo in quell’anno (e durante la mia prima villeggiatura) mi ero ritrovato a essere contendente, se n’era andata lasciando sia me che l’altro (era castano, alto, forse appassionato di modellismo) a bocca asciutta. Anche l’affine mi aveva lasciato con un saluto e una vuota promessa di rivedersi; l’avremmo fatto, forse, se fossi andato ancora in villeggiatura, ma si sarebbe trattato di un altro bambino. Così eravamo rimasti io – senza il mio complice prediletto e la ragazza che avevo inseguito per tutta la vacanza – e qualche compagno sparso. Qualunque fosse il carattere di questi sopravvissuti, ormai non faceva differenza: non c’era più modo di esprimerlo. Le tensioni si erano sciolte e non c’era nessuna posta in gioco. Vagavamo sulla spiaggia come quattro o cinque ombre, sotto un sole che batteva con sempre meno vigore, ripetendo svogliatamente i soliti giochi a palla, senza più nulla da dimostrare. La spiaggia aveva subito lo stesso destino del nostro gruppetto. C’era qualche persona gettata qua e là, un chiacchiericcio inudibile e un senso di abbandono, o di attesa della fine. Ci colpì la presenza costante di un vecchio coi capelli crespi e lunghi: solo in quel momento ci accorgemmo che era sempre stato lì, tra la folla, senza che lo notassimo mai.
La palla andava a vento più che nelle settimane precedenti. Talvolta trovavamo fredda la plastica dei tavolini. Perdemmo le carte – questo lo ricordo, perché successe solo durante quell’ultima villeggiatura. Per la prima volta, però, ero libero di attardarmi. Oltre il crepuscolo c’era la sera: scoprii che mi inquietava, perché non l’avevo mai vissuta da solo. Ma mi faceva sentire grande. Mi riempiva lo stomaco di una malinconia che sembrava venire da un’altra vita. La respiravo a petto largo. In quei momenti i miei compagni erano le ombre che sarebbero poi diventate nella memoria. Seduti sulla soglia del mare, chi a cavalcioni su un tronco, chi a gambe incrociate (io mi sono sempre seduto con le ginocchia tirate al petto), rievocavamo i momenti passati qualche giorno prima come anziani commilitoni di una guerra antica. Cercavamo una sorta di spinta vitale nella nostalgia, dato che il presente non aveva più nulla da offrire.
Fu allora che mi balenò in testa il passaggio coi rovi, quello che portava a un cancello con la vernice crepata e un lucchetto nuovo di zecca. Non avevamo mai scoperto dove sbucasse. Eppure era stato il nostro chiodo fisso per le prime settimane. Più di qualche volta, quand’eravamo ancora un gruppo che faceva invidia a una legione, ci eravamo appostati in attesa che qualcuno entrasse. Lo spericolato aveva cercato addirittura di scavalcare il cancello, ma rischiò di finire impalato sulle punte e decise che quello era un limite ragionevole persino per uno come lui. Nessuno veniva mai, ma la mattina c’erano sempre delle impronte di stivale sopra quelle dei nostri piedi nudi. Chiunque possedesse la chiave era un animale notturno, invisibile a noi che eravamo confinati tra l’alba e il crepuscolo. Adesso però era notte e noi stavamo là fuori. Proposi di andare. Gli altri si limitarono ad annuire.
Marciammo imbranati in un buio caldo e umido, calciando inavvertitamente conchiglie e sassetti, finché non ci fummo allontanati abbastanza dal chiasso sommesso degli stabilimenti in chiusura. Sono sicuro che nella nostra testa di bambini, per quanto volessimo dimostrarci cresciuti, stessimo attraversando un deserto infestato dai predoni o puntando dritti al cuore di una giungla. Posso parlare solo per me stesso, ma ricordo di aver avuto paura per un momento che mi saltasse addosso una pantera. Meglio un paio di occhi scintillanti da predatore che quello socchiuso e indecifrabile di mio padre. Non venne né lui né la pantera, e arrivammo davanti al passaggio. Era al limite della spiaggia, incastonato in un sottobosco che non dava a vedere cosa nascondesse. L’entrata era coperta da una manciata di rovi piegati in maniera innaturale, che avevamo sempre considerato un tentativo intenzionale di occultarla. C’era poca aria quella sera. Eravamo sicuri che di lì a breve avremmo svelato l’ultimo mistero di quel posto, e così sarebbe stata posta l’ultima pietra sulla tomba del nostro tempo assieme. Penso che a nessuno di noi fosse passato per la testa che oltre quel cancello ci potesse essere qualcosa di insignificante (una casa in ristrutturazione, un magazzino, un boschetto). Spostammo i rovi e ce li sentimmo ricadere alle spalle appena entrati. Il passaggio proseguiva per qualche metro scarso prima di venire bruscamente interrotto dal cancello, oltre cui il sentiero proseguiva attraverso una vegetazione ben più fitta e poi girava ad angolo. Forse qualcuno propose di scavalcarlo immediatamente, ma vedendo che non c’erano ancora impronte di stivale ci appostammo. Non potevamo rischiare che il possessore delle chiavi ci scoprisse oltre la soglia. Preferivamo aspettare che entrasse, facesse ciò che doveva e uscisse; a quel punto ci saremmo intrufolati.
Di quell’attesa ricordo solo che fu lunga, e che a ogni minuto passato (come se in quell’oscurità imprecisa potessi ancora distinguere un minuto dall’altro) temevo che i miei genitori venissero a cercarmi, o che mi stessero aspettando per punirmi. Ma il pensiero non mi scalfiva quanto avrebbe dovuto, forse grazie al particolare stato d’animo in cui mi avevano messo la malinconia e l’euforia delle prime notti d’indipendenza. Ero al di sopra delle punizioni e dei rimproveri. Intanto i grilli battibeccavano, le piante mi pizzicavano e non sapevo se stessi allucinando o meno il tocco degli insetti. Alla fine sentimmo i rovi all’entrata del passaggio muoversi e ricadere. Dall’entrata del sentiero approcciava una figura stanca. Cuore in gola. Avrei preferito una pantera. Come tutti i bambini, temevo gli umani.
Con gli occhi ormai abituati alla notte, vedemmo dal vivo quegli stivali che erano stati al centro di tante nostre congetture. Erano marroni, di buona fattura, ai piedi di una figura ossuta. Li portava quello stesso vecchio dai capelli crespi con cui avevamo a lungo condiviso la spiaggia, e che solo recentemente avevamo notato (come una conchiglia lasciata dalla marea). Ho buona ragione di credere che ci avesse visto. Fece finta di niente. Tintinnarono un paio di chiavi e i grilli sembrarono zittirsi. Vedemmo il cancello spalancarsi di fronte ai nostri occhi e il vecchio avanzare con più decisione, fino a sparire dietro l’angolo del sentiero. Mi colpì la sua faccia morbida: non aveva l’aria arcigna di un custode. Aspettammo ancora, noi, i grilli e le zanzare. C’è chi fece in tempo ad addormentarsi e svegliarsi. Mi accorsi di non poter sapere l’ora: di notte non potevo guardare il sole nel cielo. Cominciai a fremere per tornare. Uno di noi – non ricordo se lo spericolato, ma non mi pare – disse che sarebbe andato in avanscoperta. Il vecchio era là dentro da tempo ormai, ma avevamo tutti la sensazione che non sarebbe uscito prima che si avvicinasse l’aurora. Ovviamente non trattenemmo il nostro compagno: anche noialtri volevamo sapere, eravamo solo troppo codardi.
Svanì come aveva fatto il vecchio. Nelle ore seguenti (si trattava di ore?) vivemmo il paradosso di sentirci sia esploratori provetti in cerca di un segreto proibito che ragazzini impauriti dal buio e dal ritorno al campeggio. Qualcuno propose di andare a cercare il nostro compagno; nessuno ebbe abbastanza cuore da farlo. Quando ormai anche i grilli si erano stancati di frinire e noi già dibattevamo sul denunciare la scomparsa o meno, lui fece ritorno. Ci raccontò quello che aveva visto, mentre tagliavamo frettolosamente attraverso la notte per fare ritorno ai nostri letti, sperando che nessuno si fosse accorto della nostra assenza. Disse di aver trovato, dopo una mezz’ora di cammino nel mezzo di un boschetto, una villa vecchia e imponente, completamente inglobata dalla vegetazione. A sentir lui era di marmo e sembrava un tempio greco, di quelli che stavano sui libri (lo diceva semplicemente perché c’erano delle colonne). Già questo sfidava la credibilità. Diceva poi di essersi fatto strada all’interno attraverso un groviglio di stanze vuote e polverose, nella rete di un buio quasi completo, dove aveva temuto di morire. Nel momento di disperazione più profonda, aveva notato che alcune parti del pavimento erano più pulite delle altre. Seguendole aveva scoperto una scalinata monumentale e l’aveva salita. Qui arrivava la parte del racconto a cui ci sarebbe veramente piaciuto credere, ma che il nostro buonsenso ci spingeva a rifiutare completamente. Arrivato al piano di sopra, il nostro compagno ormai senza volto e senza nome diceva di aver cominciato a sentire degli strani rumori provenire da sopra la sua testa. Prima quella che sembrava una mandria di bisonti in carica e il verso di un falco. Poi, mentre navigava in cerca di un modo di accedere all’ultimo piano, il rumore del mare in tempesta; e ancora, ingranaggi che stridevano; una baraonda di clacson impazziti; silenzio; degli spari di fucile d’assalto; il ruggito di una folla in festa. Giurava sulla sua vita. Noi eravamo intrigati, ma sapevamo di essere testimoni delle fantasie di un bambino. Il racconto non finiva qui. Diceva di aver trovato le scale. Non solo: dalla cima arrivava il riflesso di una luce intensa e naturale. “Là sopra era giorno” – ricordo le parole, ma non la sua voce. “E i rumori venivano da là.” Dopo aver salito i primi tre scalini era scappato via, di nuovo nel dedalo oscuro che l’avrebbe vomitato all’esterno della villa e infine da noi. Tornammo al campeggio un’ora prima dell’alba e decidemmo di rincontrarci in spiaggia il giorno successivo, nel tardo pomeriggio. Mio padre dormiva (seppi molti anni dopo che mi aveva preceduto soltanto di qualche minuto) e mia madre non era ancora tornata. Ricorderò quel sollievo per tutta la vita. Passai la mattinata in un sonno profondo. Sognai la villa e il suo interno, prima come il grosso appartamento di un condominio, poi come un museo che avevo visitato poco tempo prima, poi come la mia scuola elementare dilatata a dismisura, poi ancora come una spiaggia al chiuso. Ogni volta salivo l’ultima scalinata. Il vecchio mi aspettava oltre la luce.
Ci ritrovammo quel pomeriggio sulla riva, seri e febbricitanti. Il mistero della villa aveva divorato le nostre vaghe nostalgie e ci aveva dato una nuova ricerca. Si erano offuscati i giochi a palla, le lotte sentimentali e i sotterfugi, i pomeriggi di sabbia e plastica, le sigarette rubate, l’occhio di mio padre, la comune ironia. Di fronte al mistero tutto perdeva consistenza. Tutto era frivolo.
La vita disseminata negli stabilimenti si faceva sempre più rada, e la spiaggia assomigliava a quella del mio sogno. Il vecchio era lì. A guardarlo alla luce, sdraiato su un vecchio telo, coi capelli legati e un paio di bizzarri occhiali da sole, sembrava ordinario come lo eravamo noi; invece condividevamo qualcosa di grandioso e interdetto. Cercavamo di evitare il suo sguardo, ma eravamo goffi. Se ne andò poco prima del tramonto. Noi restammo, ma nel sole morente trovammo solo la smaniosa attesa della notte e di quello che avrebbe rivelato. Arrivò la sera e per la prima volta sentii che era mia complice. Se c’era qualcosa da temere, era il “giorno” all’interno della villa di cui ci aveva parlato il nostro compagno. Ci incamminammo verso il passaggio per appostarci ancora. Per un istante avvertii uno sguardo addosso. Imputai la colpa al buio e alla suggestione.
Scostammo i rovi e ce li lasciammo ricadere alle spalle. Io ero davanti agli altri: fui il primo a trovarmi di fronte il cancello già aperto, e allora il sangue mi cominciò a pulsare nella testa, sentii di star precipitando e ebbi la conferma che il mondo non è fatto di pranzi al sacco, noie e costrizioni, ma che è un posto stregato, un giardino dai cunicoli infiniti, un’allucinazione; che per quelle settimane avevo camminato su un sentiero rigido e inconcludente, ma che ora mi si era spalancato davanti quello del remoto, dell’incantato, dell’impossibile, e mi invitava ad entrare. Ci precipitammo dentro. L’immagine successiva che riesco a riportare alla mente è quella della villa: sembrava di marmo, era liscia e lattiginosa e persino le edere davano un senso anomalo di pulizia. Un colonnato vigoroso la sorreggeva contro un cielo di rami. Non trovammo modo di girare intorno alla villa. Ai lati della facciata che ci eravamo trovati davanti c’era un marasma di tronchi caduti e calcinacci. Sulla soglia del portone ci aspettava una grossa torcia a pile, posta bene in vista. Qualcuno la prese; se dovessi indovinare chi, direi che si trattava del compagno andato in avanscoperta il giorno prima. Voleva la sua rivalsa sul labirinto.
Varcammo l’entrata. L’interno era realmente la confusione di stanze vuote e logore, annodate l’una sull’altra, che ci era stata descritta. La torcia fendeva attraverso una sottile nebbia di polvere. Trovammo velocemente le impronte del vecchio, vicino a quelle dei piedi nudi del nostro amico lasciate il giorno precedente. Seguendole, arrivammo facilmente alla scalinata. Salimmo un gradino; sentii vociare, rombare una macchina e poi battere un vento pesante. Sarebbe stato logico pensare di essere in un sogno. A me venne in mente che il sogno fosse la realtà a cui avevo creduto fino ai giorni precedenti. Da sopra abbaiava un cane e qualcuno gli urlava di riprendere un osso. Restammo paralizzati per qualche minuto. Potevamo distinguere chiaramente la corsa leggera del cane su un prato raso e gli incoraggiamenti del padrone. Poi si azzittirono di colpo e l’aria sembrò cambiare. Sentimmo qualcosa di metallico scontrarsi contro altro metallo. Qualcuno parlava in una vecchia lingua, che sembrava francese o tedesco. Uno di noi scappò via e non lo rivedemmo più, perché il giorno successivo era l’ultimo della sua villeggiatura. Noi ci dicemmo che la peggior cosa che poteva succedere non era la morte, ma non arrivare mai in fondo a quel mistero. Salimmo al secondo piano, mentre da sopra si alternava un gorgoglio abissale, i sussurri di qualcuno, il chiasso di un mercato (siete liberi di non credere che la mia memoria sia così precisa; d’altronde, non siete mai stati nella villa e non sapete che effetti faccia sulla mente di un uomo). Man mano che seguivamo le impronte, i rumori si facevano più forti. Venivano dal terzo piano.
La scalinata era lì, come nei miei sogni. Dall’alto, le pareti bianche di un corridoio riverberavano di una luce intensa e portavano con sé un frastuono sommesso di zoccoli che colpiscono la terra. Non ci usciva un fiato dalla bocca, né riuscivamo ad azzardare un passo. Poi successe qualcosa che ci calmò inspiegabilmente: i rumori si attenuarono, si tramutarono in un fragore distante e il giorno oltre la scalinata si fece notte. Sui muri scorgevamo un riflesso azzurrino che si gonfiava e sgonfiava, come un respiro. Sembrava il mare e sembrava un invito. Fui il primo a salire.
Alla fine di un breve corridoio c’era un’ampia stanza, in cui rimanevano le ombre di qualche affresco e null’altro. Oltre una grossa finestra scardinata svolazzava una tenda che assomigliava a una vela. Tra i suoi soffi intravedevo frammenti dell’esterno: ora una balconata semicircolare; ora una balaustra ornata di piccole colonne; ora i lunghi capelli crespi e ingrigiti di un vecchio, curvo su una sedia di legno ammuffito; ora, oltre di lui, una distesa d’acqua e di stelle. Ma non c’era modo che quella villa desse sul mare. Non so se fui io o un altro a scostare la tenda e osservare, ma ricordo il vecchio girarsi e regalarci un sorriso grande e amaro. Ci disse “Guardate, ora cambia”, o qualcosa del genere, come un nonno che porta i nipoti a vedere il circo. “Venite, venite!”
Sotto la balconata c’era l’oceano e nulla in vista. Una facciata liscia che cadeva a picco per dieci metri e l’oceano, fino all’orizzonte. E sopra si stagliava un cielo notturno, una miriade di stelle che sembravano foschia o spuma di mare, e tre lune frammentate.
“Ora cambia!” e ci investe un vento poderoso, ci si congela l’umidità addosso, poi arriva un’esplosione di luce e sotto la balconata ci sono degli spalti di arenaria e gente vestita di toghe o stracci e sotto di loro corrono due bighe e c’è chi esulta, c’è chi tifa e chi si scontra e tira pietre agli avversari – una arriva persino a noi, che siamo lì ma non siamo lì. Il vecchio si alza in piedi, indossa i suoi strani occhiali da sole e ride a pieni polmoni. Ci guarda come un bambino. Ora c’è una caligine, un vapore, e sotto la balconata c’è una distesa di fabbriche e pannelli solari; ora una prateria aranciastra sotto a un sole freddo, e un cielo tanto fioco che si vedono le stelle (il vecchio ce le indica, dice che è già la quarta volta che vede quel pianeta e che c’è una costellazione a forma di serpente di cui di giorno si vede solo la testa, ma che di notte striscia per il cielo intero).
Non svenni solo perché il vecchio continuava a ridere di gusto e parlarci come se quella fosse la normalità, una concretezza sensata, che noi avevamo finalmente scoperto tra le trame insignificanti che fino al giorno prima chiamavamo realtà. Ci disse, mentre sotto di noi degli uomini con quattro braccia cacciavano degli strani animali senza pelo su delle colline di gesso, che quella era una delle “balconate”, e che eravamo stati incredibilmente fortunati a trovarne una, perché di quei tempi cominciavano a scarseggiare. Non sapevamo che rispondere, quindi ci limitammo al silenzio. Ci sedemmo come facevamo sulla riva del mare; io con le ginocchia tirate al petto. Il vecchio si appoggiò alla balaustra e si sporse a più riprese. Ogni tanto commentava lo scenario sotto di noi. Passammo ore in quieta contemplazione. La balconata era sempre la stessa, ma il mondo là fuori era in continua metamorfosi. Posso continuare a parlarvi stentatamente di quello che vidi, anche se sarà infruttuoso.
Eravamo affacciati su una catena di monti in bufera e un esercito arrancava tra i picchi e i dirupi. Sul bordo della bocca di un vulcano ammiravamo i tremendi colpi di tosse della terra. Dal secondo piano di una locanda, gli asini trascinavano casse cariche di ortaggi per le strade di un borgo. Si affaccendavano umani e creature, umani di altri tempi e creature di altre terre. Fummo partecipi della calma arcana delle valli di un pianeta senza vita; vedemmo qualcuno giocare a palla sulle rive frastagliate di un mare denso; seguimmo con lo sguardo la rotta di un galeone che navigava il cielo; respirammo la noia molle di una villeggiatura che non era la nostra, e sui volti deformi di esseri non umani ritrovai l’affine, lo spericolato, il maturo. Sulla balconata il clima era sempre mite, anche se ci rimbalzavano ai piedi sia il ghiaccio che i lapilli. Il vecchio disse che là sopra eravamo al sicuro da tutto: persino una colata di lava ci sarebbe semplicemente scivolata addosso.
Un falco rubò la bambola di una bambina e la lasciò cadere dal cielo; ci arrivò ai piedi, e il vecchio ce la regalò come cimelio. Pensai di lanciarla giù verso la bambina, finché c’era tempo. Esitai troppo. L’universo ruotò di nuovo. Ora di bambine non c’era più traccia; una piana di fango e spire di metallo riempiva l’orizzonte.
Avevo una conchiglia nella tasca del costume. La feci precipitare nel centro di una metropoli, sulla testa di un passante. Lo guardai massaggiarsi il capo, prendere la conchiglia e guardare in alto, poi commentare qualcosa in una lingua vibrante e sconosciuta e camminare via, rigirandosela tra le mani. “Quello una conchiglia non l’ha mai vista” commentò il vecchio, poi mi disse di stare attento a interferire. Non furono le tempeste a scuoterci, né i pianeti oscuri e primordiali che ingoiavano la terra sotto di noi: furono una pallottola nel cuore di un bambino, il lamento di fame di una donna, un’amputazione nel mezzo di un deserto. Era un tempo finito ed eterno. Dinanzi a noi c’era mostruosità e meraviglia, domande poste e immediatamente risolte. Di quelle immagini sono popolati i miei sogni e i miei pensieri.
Fu il vecchio a interrompere la nostra comune meditazione. Ci raccontò che la prima volta che aveva visto una balconata era piccolo. L’aveva trovata in una casa incastonata in un muro di roccia, nella periferia della sua città natale. Si metteva lì di pomeriggio assieme a un suo amico e guardava. Era un balconcino decrepito e ferruginoso. Videro troppo e troppo in fretta. Crebbero bruscamente e non seppero più riconoscersi nei loro coetanei, né negli adulti che avrebbero dovuto educarli. Qualche anno dopo, durante uno dei loro soliti pomeriggi, il suo amico si tuffò di colpo dal balconcino; sotto c’era un mare fermo e, in lontananza, un villaggio di legno sulla riva. Ancor prima che il vecchio vedesse il corpicino dell’amico toccare l’acqua, la balconata ricominciò improvvisamente a dare sulla vegetazione della periferia, come fosse stato riportato di netto al mondo a cui apparteneva. Così imparò la prima nozione sulle balconate: quando qualcuno si tuffa, il portale si chiude. “È per questo” disse, “che se ne trovano sempre di meno.”
Aveva passato il resto della sua vita sulle tracce delle balconate. Ne faceva menzione qualche testo in greco e in sanscrito (non so se ce ne parlò così nel dettaglio; potrei star prendendo in prestito particolari dalle mie ricerche successive) ed esistevano perfino due distinte pitture rupestri che sembravano raffigurarle. Ci parlò di una strana teoria secondo cui la civiltà umana era nata e prosperata grazie alle balconate. In precedenza – diceva – il fenomeno si verificava persino su semplici costoni di roccia, sulla cresta delle colline e al limite delle scogliere. Allora il pianeta era costellato di questi portali. Osservando altri mondi, gli umani avrebbero tratto le conoscenze necessarie a fondare il proprio. Ma c’è chi cominciò a tuffarsi, perché non gli bastava contemplare. In principio (secondo la sua teoria) furono i re, che volevano condurre i propri eserciti oltre il velo per far propri gli altri mondi; poi gli esploratori, a cui stavano stretti i confini; poi anche qualche disperato, che preferiva la vaga speranza di precipitare in un’altra realtà all’idea di trascorrere tutti i propri giorni nella propria. Disse anche che gli scenari visti dalle balconate saltano di tempo in tempo, oltre che nello spazio. “Ne ho la prova.”
Chiesi se qualcuno aveva osservato anche noi da una balconata, da qualche parte nell’universo. Rispose che non solo era terribilmente probabile, ma che ne era certo. Decenni prima, la sua prima balconata aveva dato, per un momento, su un’altra balconata. Era di marmo, semicircolare, con una balaustra tenuta su da piccole colonne, e c’era un vecchio circondato da ragazzini.
In quel momento sotto di noi scrosciò ancora il mare, un mare quasi immobile, di un azzurro fresco e innocente. In lontananza c’era una riva e una città di legno. Il vecchio ci guardò, sorrise e prese la rincorsa. “Quel vecchio si tuffava.”
Prima che il suo corpo toccasse l’acqua, venimmo tirati via. Eravamo al terzo piano di una villa abbandonata nel mezzo di un boschetto, e stava venendo l’aurora. Sotto di noi c’era una vegetazione appena rischiarata dalla fine della notte, incollata assieme grezzamente, come una sorta di mosaico improvvisato. Non ricordo nulla del ritorno, se non che ancora una volta alzammo i rovi all’ingresso del passaggio e ce li lasciammo ricadere alle spalle. Forse ci pizzicammo per svegliarci. L’alba arrivò sul nostro solito mare, sul pallone ancora abbandonato sulla riva, sugli ultimi boccheggi degli stabilimenti morenti.
Trovai mio padre sulla spiaggia, con le ginocchia tirate al petto. Aspettavo una punizione; incassai maldestramente un abbraccio. Da allora il nostro rapporto migliorò nettamente. Mi svelò solo un decennio dopo che quella notte mi aveva seguito, e che aveva visto anche lui la balconata.
Ti potrebbe interessare anche: permalink