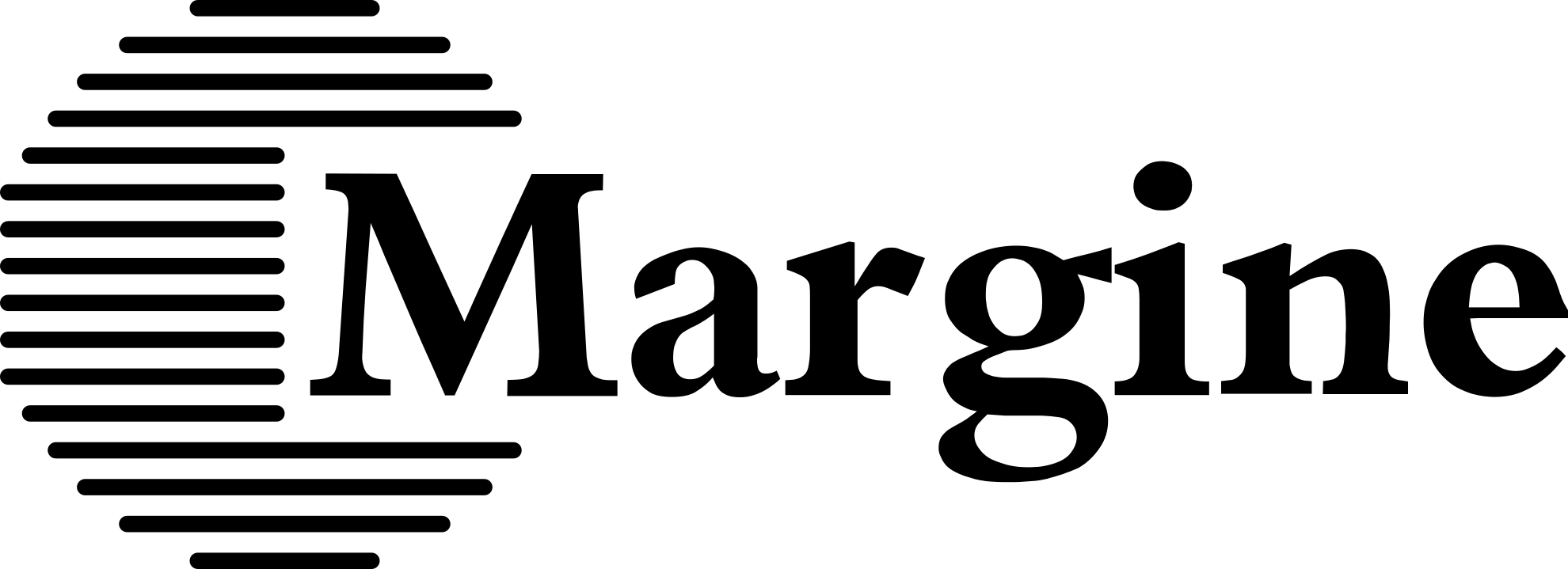Julien Beaumont

Julien Beaumont
Io sarei potuto essere Stefan Guziński, e Stefan Guziński sarebbe potuto essere me; esserci conosciuti era servito da sollievo reciproco. Mancava, tuttavia, la certezza che quella consolazione fosse fondata: nonostante fossimo affini, non potevamo certo dire di essere la stessa mente. Il me-Guziński e il Guziński-me sarebbero state due sfumature inedite al mondo. Innanzitutto perché Stefan avrebbe conservato la sua anzianità nei miei confronti, pur imbracciando la penna: la sua educazione si sarebbe comunque tenuta nei due decenni in cui io ero solamente una possibilità (ancora non immolata al tempo, al contrario dei due ipotetici presi in esame); questo avrebbe contribuito a rendere il Guziński-me meno me di quanto non sarebbe stato Guziński. Sarebbero poi venute meno delle tinte sottese del nostro rapporto a me molto care, come l’idea che a vestire i panni del mentore fosse proprio lo scienziato, e non lo scrittore; questo non per assumere la superiorità intrinseca di una materia sopra l’altra, ma solo per mettere in luce l’associazione basilare tra ragione ed esperienza che alla mia mente è sempre stata (per motivi che rimarranno anch’essi nell’ipotetico) gradita. Il Guziński scrittore lo immagino sullo stesso scranno pesante del Guziński che mi è capitato di conoscere, circondato dalla stessa quantità di libri, anche se forse i romanzi e le raccolte di racconti avrebbero fagocitato i testi tecnici. Ciononostante qualcuno sarebbe finito nello stesso posto in cui ha speso la sua esistenza reale. Se persino alla mia libreria piace la tecnica, non vedo perché quella del Guziński-me avrebbe dovuto fare eccezione. Anche in questo stava la nostra affinità: nell’aver vagliato il possibile in passato e nell’esserci dilettati a farlo – seppur in maniera minore – per il resto della vita. Sul me-Guziński ho meno parole da spendere e suonano tutte già sentite. La sua solitudine sarebbe stata la stessa, se non più acuta.
Queste sono osservazioni tagliate con la mannaia. Fanno parte di quei capricci grezzi della mente su cui tutti inciampano, prima o poi. Io e Stefan non facevamo certo eccezione. È facile nutrire pensieri del genere quando il gioco è ormai concluso: quando si è indiscutibilmente sé stessi e se n’è già data la prova al mondo – quando si è già romanzieri o dottori. Non si rischia più di sfilacciarsi, a intrattenersi con l’idea che si sarebbe potuto essere altro. Per quanto vivida sia, la figura d’argilla del me-Guziński o del Guziński-me continuerà a mostrare la propria inconsistenza davanti alla prova del reale, ai pazienti curati, alle parole inanellate negli anni. È la coperta della validazione, soprattutto, a difendere il sé della minaccia dell’ipotetico; quella tessuta lungo gli anni di carriera, sotto cui si è continuati a lievitare finché pensare di tornare impasto non è cominciata a sembrare un’assurdità. Ci sono però alcuni tra noi che si intrattengono con gli ipotetici anche prima di essere lievitati in una forma o in un’altra. In questi casi non si tratta di frivolezze con cui passare il tempo a giochi fatti. Sono i tormenti dell’impasto: quello su cui nessuno s’è ancora preoccupato di cucire una coperta, quello che è fisicamente nulla e potenzialmente ogni cosa.
Del caso Beaumont eravamo finiti a parlare in una delle nostre serate assieme1. Mirgeta e la bambina si erano ritirate a letto da un po’, la notte era avanzata e la libreria di Stefan si era – come d’abitudine – slacciata dal tempo per lasciarci conversare e, in una certa misura, conversare assieme a noi2. Julien Beaumont era un ragazzotto sulla ventina, di bell’aspetto, proveniente da una famiglia medio-borghese. Era stato preso in cura da Stefan da qualche settimana, in seguito a uno sbrigativo incontro con l’usuale disperazione dei genitori (una di quelle cose a cui è richiesto farsi il callo, se si vuol essere dottori; non farselo mai, se si vuol essere scrittori).
Stefan me lo presentò con una serie di foto che lo ritraevano, alle volte sorridente, circondato da volti a me non noti (gli affetti degli altri mi recano sempre una certa spiacevolezza – sanno di perdita), sullo sfondo degli ambienti dove ci si immaginerebbe un individuo del genere: stanze ben arredate, piazze del vecchio mondo, rive di un bianco accecante, librerie di legno massiccio e altri luoghi di studio (ho in testa di aver intravisto lì l’ala dell’università che mia figlia avrebbe poi frequentato). Mi chiese di ritenere quella carrellata come la prima stretta di mano e il primo sguardo incrociato tra me e Julien; procedette poi con quella che definì “la vostra prima conversazione”. Si trattava ancora di una serie di foto, stavolta chiaramente composte dalla stessa mano – mano che era evidentemente quella di Stefan, com’era facile dedurre dal suo tipico sguardo inquisitorio e dalla sua ricerca naturale della simmetria3.
L’occhio artificiale di Guziński s’era introdotto in camera di Julien – la stessa dov’era nato e dov’era vissuto fino all’evento – e aveva strappato via i punti che riteneva salienti alla propria investigazione, come si fa con una scena del crimine; questo risultava evidente dalla tecnica fotografica impiegata (il più obiettiva possibile) ma non dai soggetti raffigurati, che sembravano appellarsi invece a una certa curiosità documentaristica. La nostra prima conversazione consisteva, insomma, in una serie di tele lasciate a metà soltanto per passare alla prossima, in una manciata di sonetti finemente composti, in bozze di spartiti che mostravano un certo intuito melodico in divenire; e ancora in libri di fisica e biologia, in incipit di romanzi, in qualche racconto già finito (che in seguito cercai di spingere Stefan a lasciar pubblicare, senza successo); negli schizzi progettuali di diversi giardini e abitazioni, in una miriade di tesi su nuove ipotetiche forme di governo (sempre mozzate dopo qualche capitolo), nella cronistoria quasi completa di un mondo immaginario, in testi di matematica avanzata e fondamenti di chimica, in una lunga lista di mete da visitare e argomenti da approfondire, in atlanti di archeologia, in una rielaborazione ideale del modello di libreria, in una disquisizione sul ruolo delle città di cui era stato appuntato solo l’argomento portante […].
A molti piace tacciare le cose senza meta di non aver realmente niente da dire. La mia prima immaginaria conversazione con Julien era senza meta perché di cose da dire ne aveva troppe. Quella massa tumorale di brillanti ipotetici mi ricordava quella che aveva un tempo popolato la mia stanza di nascita, prima che mi convincessi che la penna fosse la mia vocazione; per meglio dire, prima che battesse le altre nella corsa per le attenzioni del mondo. Sul momento non feci menzione della cosa. Stefan procedette a mostrarmi altre foto: foto di foto, in cui le foto fotografate erano ancora una volta tutte frutto della stessa intuizione; stavolta, dedussi che fosse quella di Julien. Era affascinante, tra le altre cose, constatare la peculiare reazione chimica che si era verificata tra l’occhiata clinica della fotocamera di Stefan e quella sbrigliata, sempre rivolta al cielo, del giovane Beaumont. Mi dava l’idea di star sbirciando il modello del reale di Julien (vincolato allo strumento usato e alle circostanze degli scatti) tramite il filtro di quello di Stefan. Ovviamente, l’ultima carrellata di foto (stavolta non introdotta in alcun modo) non aveva lo scopo primario di suggerire certe riflessioni; piuttosto, capii che Stefan mi stava mostrando quelle immagini per tracciare un parallelo con la sua gioventù polverosa di fotografo. Era una silenziosa ammissione che anche la sua stanza di nascita somigliava, un tempo, a quella di Julien Beaumont.
In quanto a lui e al male che l’aveva portato nelle cure di Stefan: s’era improvvisamente fermato. C’è poco altro da dire, perlomeno per quanto riguarda l’evidenza fisica della sua condizione. Julien era fermo. Un giorno erano entrati nella sua stanza e l’avevano trovato paralizzato, a occhi chiusi, circondato dalle sue torri di creazioni e possibilità, che ora gli facevano da tumulo. Lui stava lì, un corpo inerme, ridicolo come tutti gli sconfitti che hanno peccato, in passato, di sperare nel proprio trionfo (o almeno in una disfatta non totale). Di patologie pregresse o moniti presi sotto gamba non c’era stata traccia. Aveva passato i giorni precedenti a pennellare per senso di colpa una tela lasciata a impolverarsi, a dannarsi sulla decisione presa di scrivere un racconto piuttosto che un altro, a ricordarsi ossessivamente di dover sviluppare quel trattato sulle città, a recriminarsi di non aver ancora imparato una nuova lingua e a sognare con gli amici (testimoni della cronaca qui elencata) di rivivere l’adolescenza; aveva fatto visita in una biblioteca locale per consultare un volume sull’impero partico e aveva preso il treno per visitare una chiesa a croce greca in una cittadina vicina. Qualche giorno prima si era ritirato presto da una cena di famiglia, preso da un certo sconforto che – a detta dei genitori – lo colpiva ritmicamente, per poi sbocciare nel prologo di una nuova opera, o nello studio accennato di un nuovo interesse.
A questa improvvisa paralisi nessun ambito medico aveva saputo rispondere con una motivazione certa, tantomeno con un percorso di cura (avessero sottoposto il caso a Julien stesso, magari sarebbe riuscito a idearne di verosimili). Come succede sempre, fallita ogni opzione convenzionale ci si rivolge al gemello mistico e meno attendibile della medicina: la psichiatria. Come Stefan amava ripetermi, gli psichiatri sono in fondo degli umanisti in guisa di scienziati – occupandosi dell’incomprensibile e del non misurabile, hanno in sé la tenacia indagatrice dei filosofi e la calda ostinazione dei bambini. Sono, insomma, venditori di sollievi e ipotetici. Servono a credere assieme ai disperati che una soluzione (o quantomeno una spiegazione) ci sia, e che basti tendere ancora un po’ di più le dita verso il nero per sfiorarla. Giunta la nottata del caso Beaumont, avevo ormai fatto il callo alle teorie di Stefan e avevo cominciato a masticare il suo linguaggio: era solito costruire i suoi casi su basi per la maggior parte filosofico-discorsive, per poi riportare astutamente le sue congetture verso terreni più tecnici e già battuti. Questo gli consentiva di far uso della sua intuizione (di potenziale fotografo, scrittore, progettista…) senza mai sbilanciarsi tanto da rovinarsi le vesti da dottore. Gli piaceva usarmi come camera di risonanza: un po’ perché riconosceva la nostra affinità (intravedendo forse nei miei istinti il me-Guziński che non si era mai realizzato), un po’ perché ero esente dalla rigidità di pensiero che l’educazione medica aveva conferito alla maggior parte dei suoi colleghi (al contrario loro, poi, non avevo né voglia né diritto di contestare la sua autorità).
Gli piaceva insinuare che se avessi mai scritto apertamente delle nostre conversazioni, l’avrei fatto radiare dall’albo. Ogni volta rispondevo giocosamente che prima o poi l’avrei fatto. A quel punto mi canzonava con qualcosa sulle righe di “A ripensarci fai pure”, “nessuno crede più agli scrittori, una volta finita di leggere la pagina”. Menzionarlo qui col suo nome è il mio modo di raccogliere il guanto di sfida; e poi, non può più far male. Qualsiasi cosa possa scrivere ora suonerà come un elogio. Troppi hanno mangiato quel che è lievitato dal suo impasto perché se ne ripensi la bontà. Ma ho divagato abbastanza.
Come dicevo, Stefan aveva il suo modo di avvinghiare ogni sua supposizione alle radici terrene della scienza, una volta compiute le sue disamine umanistiche. Riuscirci ogni volta era un modo di provare a sé stesso di meritare la sua posizione. Il caso Beaumont è stata l’unica eccezione a questa regola ferrea cui mi è capitato di assistere. Parlarmi della sua teoria fu per Stefan una liberazione violenta, sia dal tarlo della visione grottesca di quel corpo giovane e brillante rimasto senz’anima che dai dubbi che aveva cominciato a nutrire sulla sua stessa professionalità; e forse anche dalla realizzazione di aver a sua volta sfiorato questa tragedia, in gioventù – come d’altra parte, era ormai chiaro, avevo fatto anch’io. Fui l’unico a cui parlò delle sue ipotesi, ma se ne convinse a tal punto da tentare di curare il ragazzo sulle sue basi. A questo arriveremo in seguito.
Il dottor Stefan Guziński chiamava il male di Julien Beaumont il “dramma del possibile”. I presupposti fondamentali della sua teoria stavano nel fatto che il dramma fosse una condizione naturale di ogni individuo (questo era ovvio), ma che la quasi totalità degli individui sviluppasse autonomamente un’immunità sistematica o una cura sintomatica durante i primi venti o trent’anni di vita. Descrisse poi due grandi filtri.
Il primo filtro consiste nella realizzazione dell’incapacità. Julien Beaumont si era fermato perché si era accorto di poter brillare in ogni cosa. Io e Stefan avevamo avuto la stessa constatazione, nelle nostre rispettive gioventù. Non voglio cascare nella trappola dell’ego, e non ho intenzione di convincervi che questa nostra condizione corrispondesse a realtà; noi avevamo l’arroganza di esserne certi, ecco tutto. Sapere di poter sciogliere la pasta del proprio pensiero attorno alla forma di qualsiasi materia (artistica o scientifica che sia) e ottenerne una visione unica è una maledizione. Sapere di poter brillare in tutto è una condanna. In cosa si dovrebbe brillare, a quel punto? Non è forse un omicidio, limitarsi a essere un romanziere o un dottore? Eppure non si può essere ogni cosa. Divago. Il filtro sta in questo: nell’accorgersi, in età infantile, pre o post-adolescenziale, di non essere portati per qualcosa: di non trovarsi a casa tra figure e numeri, di non saper trovare una forma melodica alle proprie parole, di non avere il fisico per competere sportivamente o l’immaginazione per illustrare libri per bambini […]. L’albero del possibile si sfoltisce spontaneamente, com’è giusto che sia. Era successo anche a me e Stefan – e probabilmente anche a Julien –, ma con troppi pochi rami.
Il secondo filtro è l’azione ambientale, che può avvenire tramite assorbimento dell’immunità dal proprio nucleo familiare o “raccolta” fortuita degli ingredienti della cura in età infantile o preadolescenziale. Nel primo caso si parla di immunità già incubata da membri più anziani della famiglia: in queste situazioni, l’ambiente familiare (essendo composto da immuni) si dimostra sin da subito ignorante dell’esistenza del dramma stesso, e insegna indirettamente all’individuo che non c’è alcun possibile da vagliare e nessun ipotetico in cui indulgere. Il dramma del possibile (tipico delle società industriali più avanzate) viene sostituito con la consistente e sterile questione della sopravvivenza. Questa sopravvivenza non è mai realmente messa in discussione, come avveniva in tempi di minore abbondanza. Gli “immuni” prendono in prestito da quel modello del mondo – che non gli appartiene realmente – una certa forma mentale, che gli impone di tenere in considerazione solo le azioni che causino meno disagi possibili. La creazione, grande causa e sintomo del dramma, è esclusa a priori. Il costo di un’immunità del genere è un’insoddisfazione latente, un lutto quieto degli ipotetici che non si è mai saputo di aver soppresso. Chi riceve questo tipo di infusione è incapace di concettualizzare il dramma, se non in maniera passeggera, ed è perfettamente salvo dalla sua manifestazione più acuta.
Il secondo tipo di azione ambientale è aver ricevuto in dono gli ingredienti della cura, ovvero essere stati indirizzati, in modo attivo o passivo che sia. Rientrano in questa categoria i professionisti che ereditano la propria professione dall’invidia o dall’entusiasmo verso quella di un membro della famiglia (anche qui con intervento più o meno attivo da parte del famigliare stesso); chi viene diretto per proiezione verso strade precedentemente fallite da parte di una figura genitoriale; i “vocati” (spesso anch’essi per mimesi, evento traumatico, passione prematura adeguatamente nutrita…); o chi è semplicemente inciampato su qualcosa che gli ha continuato a risuonare nel cervello fino ad azzittire il resto delle possibilità. In questo caso non si tratta di immunità, ma di cura sintomatica. Questo tipo di individui riescono a comprendere il dramma. Alcuni di loro l’hanno vissuto profondamente, finché la cura non si è dimostrata abbastanza efficace. Io e Stefan abbiamo decretato, in quella nottata, di far parte di questa categoria. Lui aveva abbandonato la sua forma Beaumont a causa delle pressioni paterne, che non disdegnava; io grazie a un briciolo di validazione concessomi inaspettatamente dal mondo.
In noi permaneva, in ogni caso, una persistente nostalgia per l’irrealizzato e un peculiare tentennamento di fronte al da farsi. Questo perché il dramma non si svolge soltanto a livello macroscopico, vale a dire col pensiero che io sarei potuto essere Guziński e che Guziński sarebbe potuto essere me: si ripercuote anche in una dimensione più capillare, senza dover scomodare gli infiniti me o Guziński rimasti incompiuti. Il dramma è un mostro multiforme. Dovessi venire solo oggi a conoscenza dell’esistenza della Grecia, monterebbe in me un bisogno collerico di vederla coi miei occhi. Dovessi avere l’idea per un nuovo romanzo, dovrei ossequiarla scrivendolo. Dovessi assistere al degrado di una città che un tempo amavo, mi prenderebbe il capriccio di fondarne una nuova. Dovessi imparare la prima regola del gioco degli scacchi (che sempre mi sono impegnato ad evitare), dovrei studiarne tutto lo scibile. Dovessero arrivare tutte queste cose assieme, da quale dovrei iniziare? È questa la strada che porta a Julien Beaumont4. A me e Stefan era semplicemente stata donata una bussola funzionante. Quella di Julien invece aveva l’ago smagnetizzato, puntava un po’ ovunque. S’era fermato perché senza muoversi non poteva trovare nulla di nuovo su cui agire, e senza agire poteva smettere finalmente di brillare; aveva chiuso gli occhi perché i colori e le forme del mondo gli parlavano troppo.
Stefan mi aveva introdotto, in precedenza, al processo di sfoltimento sinaptico che tutte le specie animali operano con la maturazione cerebrale. È una fase naturale di ogni mente: all’assorbimento compulsivo (la creazione di più sinapsi di quante ce ne siano bisogno) segue la sintesi (la fondazione di un modello del mondo che sia affidabile, sacrificando il superfluo). La sua teoria era che ci fosse un qualche legame tra questo processo e la sensibilità al dramma; pensava plausibile che chi soffre di più il potenziale e l’ipotetico abbia mantenuto a livello fisiologico un po’ di quella iper-sinapticità che contraddistingue i nascituri (questo avrebbe spiegato, secondo lui, anche la distintiva flessibilità mentale di questo tipo di individui). Architetture neurali del genere, mi diceva, sono instabili di natura. In noi sarebbero collassate – stando a questa teoria – nel momento in cui avevamo soppresso ogni altra possibilità (come dovevamo) per metterci sul cammino che ci avrebbe fatto diventare me e Guziński; così non fosse stato, saremmo diventati nulla.
Julien Beaumont era diventato nulla. Julien Beaumont era un monito. Era un profeta. Tuttavia lo era solo per noi, che avevamo discusso del dramma nella penombra materna della libreria. Per gli altri, Julien Beaumont era uno sfortunato, colpito da una disgrazia incomprensibile e immeritata. Per Stefan, salvare Julien (nei lunghi giorni che avevano seguito la nostra discussione) era diventata una crociata personale, come dovesse dimostrarsi superiore al dramma stesso, o forse dimostrare a tutti gli inconsapevoli che ne soffrivano che ci fosse una scappatoia. Era ovvio che volesse salvarlo perché per un momento, decadi prima, aveva a sua volta serrato le palpebre e bloccato i muscoli. Questo Stefan non me lo confessò mai, ma gliel’ho letto tra le grinze del volto.
La cura che il dottor Guziński aveva progettato si svolgeva a porte chiuse, in una solitudine secretiva. Me ne parlò solo a caso archiviato. Era una crudeltà di cui si era vergognato a lungo. Aveva, per mesi, messo in atto quello che definiva un “filtro” artificiale; un processo di sfoltimento sinaptico forzato per cui aveva dovuto imbracciare in prima persona le cesoie. Passava le sue visite all’inerte Beaumont (divenuto in breve un simbolo sacro nel nostro linguaggio) a insinuare l’idea che dovesse proseguire, una volta sveglio, su un cammino piuttosto che un altro (il filtro ambientale); poi si camuffava la voce e ne denigrava le creazioni, convincendolo che non valessero il suo tempo (il filtro dell’incapacità). Terminava l’incontro con una serie di nastri vocali tagliati da radio e televisione per cercare di creare un ambiente organico e impersonale che funzionasse da eco ideologico, ancora una volta validando ciò che Stefan aveva deciso di validare e disfacendo le idee che aveva deciso di sfoltire. Mi confessò di aver vomitato dopo la prima seduta. Così, nell’intimità di quello spazio mentale, cronistorie immaginarie e romanzi vennero passate al diserbante; la sua intuizione melodica sfumò sotto il martello di una pressione sociale posticcia; la penna smise di desiderare l’inchiostro, gli occhi (e chissà se sognavano, quegli occhi chiusi) di bramare il mondo, la fotocamera di avere un nome (nel caso gliel’avesse dato, come aveva fatto il carnefice che tentava di svegliarlo quand’era a sua volta Julien Beaumont). Guziński aveva deciso che Julien doveva essere un architetto. Aveva vagliato il suo castello di ipotetici con rigore accademico e aveva deciso che fosse il compromesso giusto. Permaneva l’atto creativo; era a sua disposizione un percorso di studi da iniziare immediatamente (per evitare ricadute) e che l’avrebbe nutrito esame dopo esame (tessendo la famosa coperta senza cui è impossibile lievitare); avrebbe potuto lavorare appena ricevuta l’attestazione; era un ruolo che consentiva una buona posizione sociale, oltre che economica.
Schiacciata ogni cosa che brillasse, Julien Beaumont si svegliò veramente. Ci tenni a incontrarlo a mia volta. Divenimmo buoni amici, per un periodo (ne invidiavo il vigore giovanile e quella dissonante speranza che aveva sempre stampata in viso), ma quando i nostri discorsi cominciarono a divagare troppo Stefan mi intimò di lasciar perdere. Il Beaumont rinato era un ragazzotto che spiccava tra gli altri, uno di quelli col destino tatuato sulla fronte. Dava, tuttavia, l’impressione che il Julien Beaumont di cui avevamo teorizzato non fosse realmente lì, o che non ci fosse mai stato. Vissi i nostri pochi incontri nella contemplazione dell’interlocutore che sarebbe potuto essere prima del trattamento Guziński. Lo immaginavo giocoliere di arti e scienze, sempre luminoso, con l’intuito di mille uomini, ad arrovellarsi di fronte al mondo, a bramarlo in mille aspetti e a specularsi in mille versioni. Lo immaginavo cangiante, multiforme, come il dramma stesso, splendido e abominevole. Stefan aveva invece partorito da quel guscio condannato un ragazzo di un’ordinarietà stupefacente.
Quell’evento segnò una frattura temporanea tra me e Guziński. Julien Beaumont andò per la strada che il patrigno gli aveva lastricato. A ogni esame intrapreso e ogni tomo studiato, mi pare di capire, trovò le crepe del possibile ad aspettarlo: gli ipotetici di ogni cosa lasciata indietro, i fantasmi di carta straccia delle nozioni represse, l’ombra pesantissima di ciò che era rimasto non creato. A ogni linea sul foglio, simboleggiasse un muro, un tetto o un giardino, ritrovava l’immagine di una libreria reinventata, di un impero lontano di cui desiderava sapere, di un romanzo che gli sarebbe piaciuto progettare, di un vecchio trattato mai scritto sul ruolo delle città, di un mondo immaginario e della cronaca dei suoi avvenimenti che qualcuno si era curato di mettere su carta. A ogni respiro, l’ordinario Julien Beaumont si vedeva davanti lo sfolgorante Julien Beaumont, il dramma incarnato, il paralizzato, l’ogni cosa, brillante, sempre più brillante. Io e Stefan ci ritrovammo di fronte alla sua bara. Era passato meno di un anno. Porgemmo sbrigativamente le nostre ammende l’uno all’altro ed entrambi a Julien. Quella notte, quando Mirgeta e la bambina si ritirarono nelle loro stanze, ricominciammo il rituale. Fui l’unico uomo a testimoniare il pianto di Stefan Guziński.
Julien Beaumont sarebbe potuto essere me. Julien Beaumont sarebbe potuto essere Stefan Guziński. Io sarei potuto essere Stefan Guziński, lui sarebbe potuto essere me; entrambi saremmo potuti essere Julien Beaumont; entrambi lo eravamo stati, per un periodo. Entrambi continuavamo ad esserlo, in segreto, combattendo perché non si impossessasse di noi.
Quando decenni dopo vidi Stefan smagrito e contratto nella sua bara di velluto, mi venne da pensare che non fosse mai morto: che si fosse semplicemente fermato, incerto di come spendere il tempo che gli rimaneva prima della fine, nella dolorosa epifania che una volta compiuta una scelta tutto il resto sarebbe dovuto rimanere un ipotetico.
Come tutti i rituali, quelle serate davano l’idea d’essere un’unica lunga sera, intervallata ma mai realmente interrotta dal resto della vita (una piccolezza lontana e ininfluente, quando dopo cena ci si sedeva in libreria e il rituale ricominciava com’era sempre destinato a fare). ↩︎
Verrebbe facile dire che in quel luogo trovassi una casa mai avuta; mentirei. Non era la libreria ad essere casa: casa stava nell’unione metamorfica tra il luogo, la familiarità, me, Stefan, la conversazione del momento e ogni conversazione avvenuta in precedenza su quelle due sedie; casa era il rituale, la libreria era la crisalide che la incubava. ↩︎
In una gioventù che predava l’esistenza del dottor Guziński, Stefan si era innamorato dell’idea di vivere e ricavarsi da vivere attraverso la lente della sua fotocamera; mi confessò in seguito di averle dato il nome di “Nozy” (abbreviazione di “Nożyce”) e di accudirla ancora. ↩︎
Lo avverto tutt’ora il dramma, redigendo parole che potrebbero essere altre, o almeno poste in un ordine diverso. Questo testo vi arriverà rilegato assieme agli altri; per me, conoscendo il calvario della sua scrittura, sarà sempre un delirio solitario. Ci sto su da settimane. Si continuano a mettere di mezzo tutti gli altri frammenti che questo frammento potrebbe essere. Vi confesso di aver pensato per un momento di scrivere un libro che raccontasse solo di questa vicenda in ogni modo possibile; poi mi sono detto che la stesura non sarebbe finita mai, e che sarebbe stata una liberazione troppo a buon mercato.
Poscritto: Il dramma è l’impulso umano di essere ogni cosa, creare ogni cosa, esperire ogni cosa; scrivere del dramma è in sé il dramma. ↩︎
Ti potrebbe interessare anche: permalink