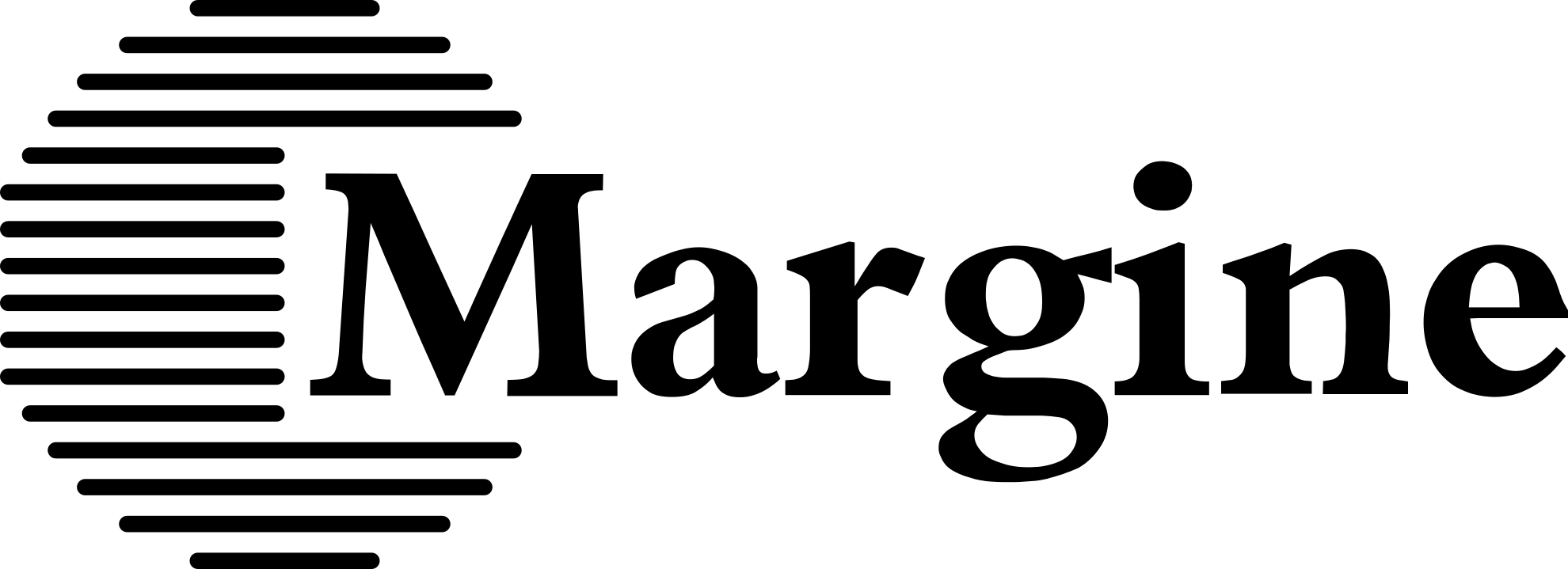Genova

Genova
Nel saggio Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria di Marshall Berman, l’esperienza della modernità trascende la definizione meramente temporale per assumere i connotati di una condizione esistenziale, caratterizzata da connubi inquietanti di progresso e angoscia, di potere e disgregazione: ne esce un mondo che, nel suo accelerare vorticoso, minaccia di distruggere ogni certezza. La vita moderna, in questa visione, è un’esistenza sospesa in un movimento perpetuo dove ogni solidità si dissolve.
Pochi scrittori sono stati capaci di incarnare quest’esperienza turbolenta con la stessa radicalità di Dino Campana. Se da un lato la sua biografia è un vero e proprio calvario di nomadismo, ricoveri psichiatrici e incomprensione, dall’altro l’opera di Campana racchiude l’aspirazione a cogliere “il violento groviglio delle forze nelle città elettriche”1. La frammentazione, il dinamismo e la disperata ricerca di senso che caratterizza il vissuto dei moderni secondo Berman sono infatti alcuni dei grandi temi che Campana affronta nei suoi versi, con un approccio senza eguali nella letteratura italiana del tempo: la sintassi frantumata, l’ossessione per la città e la figura di artista alienato, marginale rispetto al canone, confermano la modernità di Campana e la sua partecipazione totale al dinamismo incessante del mondo, davanti a cui non si può che restare ammirati e terrorizzati.
La città diventa, nell’opera di Campana, un palcoscenico febbrile della modernità, di cui viene pienamente colta la brulicante e sonora animazione. Il randagismo esistenziale dell’autore, che lo portò a vagare senza meta per l’Europa e per il Sud America, è la perfetta espressione biografica del senso di sradicamento e movimento perpetuo che Berman aveva identificato come la condizione dell’uomo moderno.
Campana, la cui patologia mentale aveva già iniziato a manifestarsi da giovanissimo, nel 1913 consegnò a Giovanni Papini e Ardengo Soffici, allora redattori della rivista Lacerba e principali esponenti dello scenario letterario fiorentino, il manoscritto originale dei Canti Orfici, con il titolo Il più lungo giorno. Dopo mesi trascorsi ad attendere un riscontro, Campana tornò a Firenze per recuperare l’opera, ma gli venne detto che era stata smarrita. Nonostante la perdita abbia gettato il poeta in uno stato di rabbia e disperazione, con un enorme sforzo mentale e con l’affidamento alla memoria e a bozze sparse, Campana riscrisse il libro nell’inverno del 1914, con numerose modifiche e aggiunte. Lo fece stampare a proprie spese dal tipografo Bruno Ravagli di Marradi. Dopo la pubblicazione, l’opera ricevette l’attenzione dei critici, con articoli di Giuseppe De Robertis (La Voce, 1914) e Giovanni Boine ed Emilio Cecchi (La Riviera Ligure e La Tribuna, 1915). Eugenio Montale fu tra i suoi primi e più autorevoli estimatori ufficiali, che riconobbe in Campana il merito di aver saputo piegare le parole, fino a renderle più oscure. Carmelo Bene, in seguito, lo riterrà il più grande poeta italiano del Novecento dopo Dante, per la sua capacità di presentare la “forma aperta contro la forma chiusa" della scrittura poetica.
I Canti Orfici sono caratterizzati da una coesione feroce tra la scrittura poetica formale, la Weltanschauung e le dinamiche psichiche del poeta. L’opera è un campo in perenne movimento, che al tempo stesso appare riconducibile a pochissime costanti, formali e tematiche. La struttura è dominata da una diffusione onnipervasiva e radicale di tecniche di iterazione (ripetizione ossessiva di moduli e immagini), che propone l’esperienza come un infinito ripetersi, in un richiamo al concetto nietzschiano dell’eterno ritorno. L’uso drammatico dei superlativi e l’effetto d’eco nelle preposizioni sono caratteristiche evidenti, d’altronde, fin dalle prime prose inserite nella raccolta.
Campana si approccia alla metrica con piena consapevolezza versoliberista: I versi hanno lunghezza estremamente variabile e oscillano tra il quinario e il decasillabo, con un’evidente incongruenza che non mette comunque in secondo piano il ricorso all’endecasillabo classico. In alcuni componimenti, l’uso del verso lungo è dominato da una logica meramente accumulativa: al suo interno vi trovano infatti spazio accostamenti ridondanti di richiami e suggestioni che sembrano spingere all’estremo la ritmicità dei componimenti. Il vero tratto distintivo dello stile dei Canti Orfici, tuttavia, è la sintassi che appare spesso intricata e sconnessa, al punto da portare la critica a sminuirne il valore, definendo la poetica di Campana un “balbettio demente”2. Il ritrovamento postumo del manoscritto Il più lungo giorno (nel 1971, tra le carte di Soffici a Poggio a Caiano) ha tuttavia dimostrato che le presunte aberrazioni logico-sintattiche erano il risultato di uno studio esigentissimo di stile e non frutto di dissociazione psichica. La disarticolazione logico-sintattica è stata una conquista formale voluta dall’autore, in sintonia con le ricerche delle arti pittoriche contemporanee, in particolar modo del cubismo e futurismo. L’obiettivo finale era quello di creare nessi che inducessero letture plurime e stratificate.
Vi proponiamo in lettura la poesia “Genova”, l’ultima nell’antologia, per analizzarne le caratteristiche fondamentali. Si tratta di una delle più lunghe e complesse nei Canti Orfici, nonché tra le più interessanti da considerare per comprendere la portata innovativa dello stile metrico di Dino Campana.
# Genova
Poi che la nube si fermò nei cieli
Lontano sulla tacita infinita
Marina chiusa nei lontani veli,
E ritornava l’anima partita
Che tutto a lei d’intorno era già arcana-
mente illustrato del giardino il verde
Sogno nell’apparenza sovrumana
De le corrusche sue statue superbe:
E udii canto udii voce di poeti
Ne le fonti e le sfingi sui frontoni
Benigne un primo oblio parvero ai proni
Umani ancor largire: dai segreti
Dedali uscii: sorgeva un torreggiare
Bianco nell’aria: innumeri dal mare
Parvero i bianchi sogni dei mattini
Lontano dileguando incatenare
Come un ignoto turbine di suono.
Tra le vele di spuma udivo il suono.
Pieno era il sole di Maggio
Sotto la torre orientale, ne le terrazze verdi ne la lavagna cinerea
Dilaga la piazza al mare che addensa le navi inesausto
Ride l’arcato palazzo rosso dal portico grande:
Come le cateratte del Niagara
Canta, ride, svaria ferrea la sinfonia feconda urgente al mare:
Genova canta il tuo canto!
Entro una grotta di porcellana
Sorbendo caffè
Guardavo dall’invetriata la folla salire veloce
Tra le venditrici uguali a statue, porgenti
Frutti di mare con rauche grida cadenti
Su la bilancia immota:
Così ti ricordo ancora e ti rivedo imperiale
Su per l’erta tumultuante
Verso la porta disserrata
Contro l’azzurro serale,
Fantastica di trofei
Mitici tra torri nude al sereno,
A te aggrappata d’intorno
La febbre de la vita
Pristina: e per i vichi lubrici di fanali il canto
Instornellato de le prostitute
E dal fondo il vento del mar senza posa,
Per i vichi marini nell’ambigua
Sera cacciava il vento tra i fanali
Preludii dal groviglio delle navi:
I palazzi marini avevan bianchi
Arabeschi nell’ombra illanguidita
Ed andavamo io e la sera ambigua:
Ed io gli occhi alzavo su ai mille
E mille e mille occhi benevoli
Delle Chimere nei cieli:……
Quando,
Melodiosamente
D’alto sale, il vento come bianca finse una visione di Grazia
Come dalla vicenda infaticabile
De le nuvole e de le stelle dentro del cielo serale
Dentro il vico marino in alto sale,……
Dentro il vico chè rosse in alto sale
Marino l’ali rosse dei fanali
Rabescavano l’ombra illanguidita,……
Che nel vico marino, in alto sale
Che bianca e lieve e querula salì!
«Come nell’ali rosse dei fanali
Bianca e rossa nell’ombra del fanale
Che bianca e lieve e tremula salì:…» —
Ora di già nel rosso del fanale
Era già l’ombra faticosamente
Bianca……
Bianca quando nel rosso del fanale
Bianca lontana faticosamente
L’eco attonita rise un’irreale
Riso: e che l’eco faticosamente
E bianca e lieve e attonita salì……
Di già tutto d’intorno
Lucea la sera ambigua:
Battevano i fanali
Il palpito nell’ombra.
Rumori lontano franavano
Dentro silenzi solenni
Chiedendo: se dal mare
Il riso non saliva…
Chiedendo se l’udiva
Infaticabilmente
La sera: a la vicenda
Di nuvole là in alto
Dentro del cielo stellare.
Al porto il battello si posa
Nel crepuscolo che brilla
Negli alberi quieti di frutti di luce,
Nel paesaggio mitico
Di navi nel seno dell’infinito
Ne la sera
Calida di felicità, lucente
In un grande in un grande velario
Di diamanti disteso sul crepuscolo,
In mille e mille diamanti in un grande velario vivente
Il battello si scarica
Ininterrottamente cigolante,
Instancabilmente introna
E la bandiera è calata e il mare e il cielo è d’oro e sul molo
Corrono i fanciulli e gridano
Con gridi di felicità.
Già a frotte s’avventurano
I viaggiatori alla città tonante
Che stende le sue piazze e le sue vie:
La grande luce mediterranea
S’è fusa in pietra di cenere:
Pei vichi antichi e profondi
Fragore di vita, gioia intensa e fugace:
Velario d’oro di felicità
È il cielo ove il sole ricchissimo
Lasciò le sue spoglie preziose
E la Città comprende
E s’accende
E la fiamma titilla ed assorbe
I resti magnificenti del sole,
E intesse un sudario d’oblio
Divino per gli uomini stanchi.
Perdute nel crepuscolo tonante
Ombre di viaggiatori
Vanno per la Superba
Terribili e grotteschi come i ciechi.
Vasto, dentro un odor tenue vanito
Di catrame, vegliato da le lune
Elettriche, sul mare appena vivo
Il vasto porto si addorme.
S’alza la nube delle ciminiere
Mentre il porto in un dolce scricchiolio
Dei cordami s’addorme: e che la forza
Dorme, dorme che culla la tristezza
Inconscia de le cose che saranno
E il vasto porto oscilla dentro un ritmo
Affaticato e si sente
La nube che si forma dal vomito silente.
O Siciliana proterva opulente matrona
A le finestre ventose del vico marinaro
Nel seno della città percossa di suoni di navi e di carri
Classica mediterranea femina dei porti:
Pei grigi rosei della città di ardesia
Sonavano i clamori vespertini
E poi più quieti i rumori dentro la notte serena:
Vedevo alle finestre lucenti come le stelle
Passare le ombre de le famiglie marine: e canti
Udivo lenti ed ambigui ne le vene de la città mediterranea:
Ch’era la notte fonda.
Mentre tu siciliana, dai cavi
Vetri in un torto giuoco
L’ombra cava e la luce vacillante
O siciliana, ai capezzoli
L’ombra rinchiusa tu eri
La Piovra de le notti mediterranee.
Cigolava cigolava cigolava di catene
La grù sul porto nel cavo de la notte serena:
E dentro il cavo de la notte serena
E nelle braccia di ferro
Il debole cuore batteva un più alto palpito: tu
La finestra avevi spenta:
Nuda mistica in alto cava
Infinitamente occhiuta devastazione era la notte tirrena
“Genova” simboleggia l’apice della tensione conoscitiva del poeta, che si ritrova pienamente immerso nel Mito. Il componimento si apre con l’immagine della nube che si ferma nei cieli: un segno che il tempo si è immobilizzato nella pienezza di una condizione eterna ed essenziale, non soggetta alla caducità. Uscendo dai vicoli genovesi, il poeta non è che un voyant rispetto alla vastità indefinita del panorama marino. Campana ammise che la poesia faceva parte dei suoi ricordi di viaggio: l’esperienza della memoria, come si vedrà, è una caratteristica fondamentale dell’intera composizione poetica.
La poesia è il risultato dell’assemblaggio di almeno cinque testi autonomi presenti ne Il più lungo giorno. Confrontando il testo con il manoscritto, si trova una sua versione primordiale con il titolo Il canto di Genova. Preludii mediterranei. Le sette sezioni in cui è divisa “Genova" sono state spesso (e impropriamente) chiamate “strofe”: la critica suggerisce che dovrebbero essere definite semplicemente “parti” a causa della loro estrema irregolarità3. Tra queste, è la quarta parte ad aver ricevuto la maggiore attenzione da parte degli studiosi. Giovanni Boine, già letterato di spicco dei Vociani, parlò di un momento in cui “la vertigine vince” e le parole, spersi come echi, “si frantumano in ansia d’espressione,” dando lo “spasimo dell’inesprimibile”4. Notò che la musicalità del verso vinceva la logica, e “la cosa da dire, è l’allucinata febbre”. Carlo Bo, in un suo saggio del '37, sostenne invece che fosse Campana a non essere più in grado di parlare, vedendo la ripetizione come un inciampo e un segno d’impotenza dovuto all’ansia5.
Alessandro Parronchi fu il primo a suggerire che la scomposizione e frammentazione dei piani in “Genova” corrispondesse alle ricerche tecniche delle arti pittoriche contemporanee, come il futurismo e il cubismo6. Campana, infatti, era interessato all’arte post-simbolista, il cui segreto risiede non nel motivo ma nel “collegamento” e nel “punto di fusione” fra gli oggetti. La critica ha osservato che la destrutturazione sintattica della quarta parte potrebbe essere il tentativo consapevole di Campana di tradurre la dinamica della visione, in un’armonia “cinematografica” di pittura e musicalità in sequenze ripetute. Carmelo Bene vedeva nella ripetizione delle varianti genovesi il “rovello di un labirinto mentale e l’ansia tecnica della formulazione di un’armonia”7.
Il tema centrale della quarta sezione è la descrizione della “visione di Grazia”, un’apparizione che Campana tenta disperatamente di assecondare e riprodurre, portando la poesia ad acrobazie sintattiche che quasi ne vanificano il senso. Tale visione è dipinta attraverso la dialettica rosso/bianco. Il “bianco” della visione che sale (ripetuto sette volte) si contrappone al “rosso” dei fanali (ripetuto sei volte), dove il rosso è il corrispettivo cromatico della condizione dolorosa dell’uomo.
La poesia si conclude con una visione notturna che riafferma la dialettica ombra-luce, dolore-speranza. Il ritmo ciclico è evidente: la fine del viaggio (la notte tirrena) è anche il suo principio, e la partenza e il ritorno sono la stessa cosa. Campana, nonostante la ricerca di un "più chiaro giorno di Genova”, trova alla fine una “infinamente occhiuta devastazione”.
A chiusura dell’intera opera, Campana inserisce un colophon, o epigrafe finale, che sembra condensare il tragico destino del poeta. La frase in questione è un verso ripreso e manipolato dal poeta americano Walt Whitman, tratto specificamente da Song of Myself (canto 34):
“They were all torn and covered with the boy’s blood”
Campana stesso fornì una traduzione della frase al suo psichiatra, Carlo Pariani, durante i colloqui che svolse a Castel Pulci, traducendola come: “Erano tutti stracciati e coperti col sangue del fanciullo”.
Campana riteneva queste parole di Whitman “le uniche importanti del libro”8. La scelta di questa citazione è necessariamente legata alla visione che Campana aveva di sé stesso, della sua opera, e del suo rapporto conflittuale con l’ambiente letterario e la società in generale. In una lettera a Emilio Cecchi del 1916, scagliandosi contro i letterati fiorentini, asserì che “tutti i fiorentini sono tracciati di assassinio anch’essi covered with the boy’s blood”9. Il sangue del fanciullo/ragazzo (cioè il poeta) è una metafora dell’atto di violenza subito per mano dell’ambiente fiorentino a lui ostile, che definiva in una lettera “focolaio di càncheri”10. La citazione, che conclude un intenso e faticoso viaggio orfico, sembra suggerire che la forza della Storia impone sempre un destino di sangue al poeta che tenta di svelarla. Inoltre, riprendendo il tema della morte di Orfeo per mano delle Baccanti (raccontato dal poeta latino Virgilio), Carmelo Bene considera la parola poetica in Campana come “musica fanciulla esangue”11. Il colophon di Whitman simboleggiava lo “sparagmòs orfico”, ovvero lo smembramento mitico di Orfeo, e annunciava che l’attore-poeta doveva fare a pezzi la sua identità e dissanguare i suoi versi12. Per Bene, “non si può raggiungere l’originario senza un massacro”, cioè un’opera di negazione esercitata sulle parole13. La frase di Whitman sigillava i Canti con il “sangue della parola poetica”, permettendo di recuperare dalla Poesia “la vita invece che il senso”. L’interpretazione di Bene, quindi, trasforma la citazione da un lamento biografico in uno strumento sapiente per la ricerca del vuoto e dell’originario al di là della logica narrativa o del linguaggio-rappresentazione.
Simbolicamente, è “coperto con il sangue del ragazzo” che persino il lettore conclude il suo viaggio attraverso i Canti Orfici: dopo la chiusura mitica sullo scorcio marino di Genova e la visione di Grazia, non si può che restare scossi dalla mutilazione linguistica che ha compiuto Campana con i suoi stessi versi. Mutilazione che, tuttavia, rivela una grande tensione artistica ed è simbolo di un approccio poetico non solo innovativo per il primo Novecento, ma anche, come si è visto, pionieristico rispetto alle tendenze filosofiche e tematiche di molta poesia che sarebbe stata pubblicata nei decenni a venire.
Pariani, C. e Campana, D., Vita non romanzata di Dino Campana; lettere scelte (1910-1931), a cura di Tiziano Gianotti. Firenze, Ponte alle Grazie, 1994, p. 84. ↩︎
Bonaffini, L., Ordine e disordine in Campana: “Genova” e la questione della quarta strofa, in Forum Italicum, vol. 13, no. 3, 1979, p. 346. ↩︎
Giovannetti, P., Per una lettura di Genova. Su metrica e sintassi di Dino Campana, in F. Latini e S. Giusti (a cura di), Per leggere i classici del Novecento, Loescher Editore, Torino, 2017, p. 86. ↩︎
Bonaffini, L., Ordine e disordine in Campana: “Genova” e la questione della quarta strofa, in Forum Italicum, vol. 13, no. 3, 1979, p. 345. ↩︎
Ibidem, p. 346. ↩︎
Ibidem, p. 347. ↩︎
cfr. Quadri, F., Con Carmelo Bene nella follia del poeta, «La Repubblica», 18 febbraio 1995. ↩︎
Pariani, C. e Campana, D., Vita non romanzata di Dino Campana; lettere scelte (1910-1931), a cura di Tiziano Gianotti. Firenze, Ponte alle Grazie, 1994, p. 122. ↩︎
Ibidem p. 123. ↩︎
Ibidem p. 84. ↩︎
Piazza, L., Volte: e le cose già non sono più, Mimesis Journal, 6, 2 | 2017, p. 69 ↩︎
Ibidem, p. 75. ↩︎
cfr. Artioli, U. e Bene, C., Un dio assente. Monologo a due voci sul teatro, a cura di A. Attisani e M. Dotti, con scritti di E. Fadini e G. Zuccarino, postfazione di C. Sini, Milano, Medusa, 2006, p. 125 ↩︎
Ti potrebbe interessare anche: permalink